Le ombre danzanti delle Dolomiti
Ombra e fuoco. In questa prateria alpina, a fianco delle montagne, i colori oscillano tra due poli. Un polo d’ombra, con il verde scuro delle foreste di pino cembro, abete bianco, frassino, ma ancor più con la gamma opaca dei colori del versante in ombra, la facciata maledetta di tutte le montagne. È certamente il territorio selvaggio dell’orso timido, che compie i suoi percorsi in un mondo clorofilliano di cespugli, abetaie severe, piante da bacca, carcasse abbandonate e caverne; è il mondo del primo tra i cacciatori, dalla spessa pelliccia ombrosa che si spande dal muso primitivo nel verde acido e nel marrone odoroso.
Sul versante soleggiato domina il polo del fuoco, quando nulla riesce a filtrare i colori vividi delle montagne, perché nessuno scenario urbano né intempestive nuvole di fumo possono respingerli, per folle disprezzo, sullo sfondo. È allora che il colore, come nei quadri di Segantini, acquisisce scaglie di fuoco; scintilla, vibra, impone la sua forza. Diventa un serpente dalle molte teste. È materia in libertà. In Val Nambrone, sale lungo il granito come una mano beige, grigia, smeraldo, prima di essere toccata dall’ossigeno delle vette e di evaporare in un blu ceruleo; più in basso crea poi delle trecce vegetali che talvolta s’intrufolano tra due massi di granito. Sotto Campiglio, dove i pesanti chalet disposti a imbuto sono ornati di fiori, le abetaie impellicciano i ripidi pendii che portano alla cascata di Vallesinella. Là il blu azzurrino delle cascate è così veloce da sembrare invisibile.
Val Nambrone. Si alternano i poli di luce e d’ombra. I colori circolano come quella rena che dona il turchese ai fiumi. Nel polo d’ombra si muovono i puntini violetti dei mirtilli, bacche dapprima invisibili, che poi si scorgono all’improvviso, fino a non vedere niente altro. E ancora, di nuovo, il fuoco, la prateria dove gira la ruota del tempo, i musi caldi e lucenti delle mucche della Val Rendena che frugano tra i cardi, intorno a una di quelle malghe che appartenevano alla nobiltà paesana. Più in alto si susseguono i laghi, il più grande e il più lontano è di un blu profondo, e talvolta opaco. Il più piccolo, invece, è una goccia trasparente rotolata ai piedi del monte, che vi si riflette schietto e definito. Sulla strada bianca del ritorno, colore del talco, del gesso (il sole sta preparando la sua ritirata), dei ciottoli macchiettati, punti neri sul bianco, continuano il gioco dei colori nel microcosmo, finché in basso tutto il paesaggio ritrova la sua ombra malinconica e il cielo diventa blu di Prussia.
In lontananza, tutti i colori apparsi di giorno si riuniscono ai piedi delle Dolomiti del Brenta, poi risalgono e si annodano in fasci pietrificati sulla verticale delle falesie senza crepe.
Perché avviene qualcosa, là in alto, tra le torri e le scalinate, sulle facciate lisce e scrostate, sui pianori lunari. Rosee e fresche al mattino, le Dolomiti ingialliscono a mezzogiorno, rinverdiscono al pomeriggio come invase fin dalle radici dai colori che si irradiano dai coni degli abeti, fino ad assumere, alla sera, le tinte dell’indaco striate da un rosso vivo. Per tutta la giornata si imbevono di luce come spugne sottomarine e irradiano come i coralli che furono in passato.
Esiste un’oscurità dolomitica? Danno ombra come le altre montagne, di arenaria, di scisto, di granito? In questa estate ne dubito, perché i monti pallidi non portano la loro massa ombrosa sulla natura prigioniera di queste grandi muraglie porose, di calcare e di magnesio. Restano distanti come la Luna, la cui onnipresenza è sempre colorata di discrezione. È lontana, serica, fredda. E le montagne sono lontane, fredde, seriche. La loro plasticità è chiara, perfetta, sempre commovente.
Rivedendo il passato, ricordo le montagne delle Alte Alpi o dell’Isère in Francia, inverni malinconici. L’ombra delle montagne è pesante, spietata, vi si mescola la pietra e la massa inerte; è l’ora in cui la montagna schiaccia passivamente, nella sua ombra opprimente, ciò che aveva fino ad allora passivamente dominato.
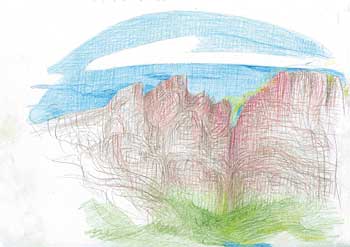 Ma
ecco l’estate e le Dolomiti di notte continuano a brillare sotto la
luna, tornando come una marea mattutina, riportate dall’oriente che le
illumina. Scorgo monti trasparenti, translucidi; mentre vado da Madonna
di Campiglio a Pinzolo, per la strada a tornanti, vedo apparire a
intervalli regolari, anche se in modo furtivo, la loro carne palpitante
che non sa produrre ombra.
Ma
ecco l’estate e le Dolomiti di notte continuano a brillare sotto la
luna, tornando come una marea mattutina, riportate dall’oriente che le
illumina. Scorgo monti trasparenti, translucidi; mentre vado da Madonna
di Campiglio a Pinzolo, per la strada a tornanti, vedo apparire a
intervalli regolari, anche se in modo furtivo, la loro carne palpitante
che non sa produrre ombra.
Ombra e fuoco. In questa prateria alpina, a fianco delle montagne, i colori oscillano tra due poli. Un polo d’ombra, con il verde scuro delle foreste di pino cembro, abete bianco, frassino, ma ancor più con la gamma opaca dei colori del versante in ombra, la facciata maledetta di tutte le montagne. È certamente il territorio selvaggio dell’orso timido, che compie i suoi percorsi in un mondo clorofilliano di cespugli, abetaie severe, piante da bacca, carcasse abbandonate e caverne; è il mondo del primo tra i cacciatori, dalla spessa pelliccia ombrosa che si spande dal muso primitivo nel verde acido e nel marrone odoroso.

Sul versante soleggiato domina il polo del fuoco, quando nulla riesce a filtrare i colori vividi delle montagne, perché nessuno scenario urbano né intempestive nuvole di fumo possono respingerli, per folle disprezzo, sullo sfondo. È allora che il colore, come nei quadri di Segantini, acquisisce scaglie di fuoco; scintilla, vibra, impone la sua forza. Diventa un serpente dalle molte teste. È materia in libertà. In Val Nambrone, sale lungo il granito come una mano beige, grigia, smeraldo, prima di essere toccata dall’ossigeno delle vette e di evaporare in un blu ceruleo; più in basso crea poi delle trecce vegetali che talvolta s’intrufolano tra due massi di granito. Sotto Campiglio, dove i pesanti chalet disposti a imbuto sono ornati di fiori, le abetaie impellicciano i ripidi pendii che portano alla cascata di Vallesinella. Là il blu azzurrino delle cascate è così veloce da sembrare invisibile.
Val Nambrone. Si alternano i poli di luce e d’ombra. I colori circolano come quella rena che dona il turchese ai fiumi. Nel polo d’ombra si muovono i puntini violetti dei mirtilli, bacche dapprima invisibili, che poi si scorgono all’improvviso, fino a non vedere niente altro. E ancora, di nuovo, il fuoco, la prateria dove gira la ruota del tempo, i musi caldi e lucenti delle mucche della Val Rendena che frugano tra i cardi, intorno a una di quelle malghe che appartenevano alla nobiltà paesana. Più in alto si susseguono i laghi, il più grande e il più lontano è di un blu profondo, e talvolta opaco. Il più piccolo, invece, è una goccia trasparente rotolata ai piedi del monte, che vi si riflette schietto e definito. Sulla strada bianca del ritorno, colore del talco, del gesso (il sole sta preparando la sua ritirata), dei ciottoli macchiettati, punti neri sul bianco, continuano il gioco dei colori nel microcosmo, finché in basso tutto il paesaggio ritrova la sua ombra malinconica e il cielo diventa blu di Prussia.
In lontananza, tutti i colori apparsi di giorno si riuniscono ai piedi delle Dolomiti del Brenta, poi risalgono e si annodano in fasci pietrificati sulla verticale delle falesie senza crepe.
Perché avviene qualcosa, là in alto, tra le torri e le scalinate, sulle facciate lisce e scrostate, sui pianori lunari. Rosee e fresche al mattino, le Dolomiti ingialliscono a mezzogiorno, rinverdiscono al pomeriggio come invase fin dalle radici dai colori che si irradiano dai coni degli abeti, fino ad assumere, alla sera, le tinte dell’indaco striate da un rosso vivo. Per tutta la giornata si imbevono di luce come spugne sottomarine e irradiano come i coralli che furono in passato.
Esiste un’oscurità dolomitica? Danno ombra come le altre montagne, di arenaria, di scisto, di granito? In questa estate ne dubito, perché i monti pallidi non portano la loro massa ombrosa sulla natura prigioniera di queste grandi muraglie porose, di calcare e di magnesio. Restano distanti come la Luna, la cui onnipresenza è sempre colorata di discrezione. È lontana, serica, fredda. E le montagne sono lontane, fredde, seriche. La loro plasticità è chiara, perfetta, sempre commovente.
Rivedendo il passato, ricordo le montagne delle Alte Alpi o dell’Isère in Francia, inverni malinconici. L’ombra delle montagne è pesante, spietata, vi si mescola la pietra e la massa inerte; è l’ora in cui la montagna schiaccia passivamente, nella sua ombra opprimente, ciò che aveva fino ad allora passivamente dominato.
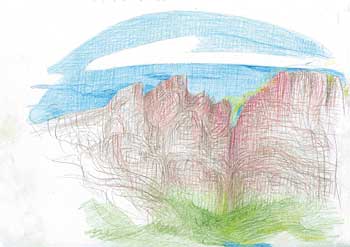 Ma
ecco l’estate e le Dolomiti di notte continuano a brillare sotto la
luna, tornando come una marea mattutina, riportate dall’oriente che le
illumina. Scorgo monti trasparenti, translucidi; mentre vado da Madonna
di Campiglio a Pinzolo, per la strada a tornanti, vedo apparire a
intervalli regolari, anche se in modo furtivo, la loro carne palpitante
che non sa produrre ombra.
Ma
ecco l’estate e le Dolomiti di notte continuano a brillare sotto la
luna, tornando come una marea mattutina, riportate dall’oriente che le
illumina. Scorgo monti trasparenti, translucidi; mentre vado da Madonna
di Campiglio a Pinzolo, per la strada a tornanti, vedo apparire a
intervalli regolari, anche se in modo furtivo, la loro carne palpitante
che non sa produrre ombra.
Il fattore Cheval e le Dolomiti
Che cosa vedo, che cosa ho visto guardando le Dolomiti? Merletti, guglie, pinnacoli, torri, archi di spinta, ogive; poi campanili, cupole, altre torri, ma anche coralli, spugne e conchiglie, mille cose frammiste e sedimentate, che avrei potuto scorgere anche sulle facciate del palazzo del fattore Cheval, a Hauterives. Guardando indietro, penso al palazzo dei sogni e al fattore Cheval, un artista eroico che ha passato la vita a costruire, pietra dopo pietra, il suo tempio della natura (poi detto Palazzo dei sogni), nelle colline della Drôme, in Francia. Non c’è dubbio che il fatto stesso di vivere vicino ai contrafforti delle Alpi abbia ispirato il nostro eroe, visto che il suo palazzo è un accumulo geo-archeologico, come il tempio di Angkor o i templi induisti dell’India. Il vegetale vi si affianca al minerale; la sedimentazione degli stili lo rende quasi un’opera naturale, al tempo stesso ingenua e sacra. Lo stesso vale per le Dolomiti, che avrebbero confermato, se l’avessero vista, l’intuizione iniziale del fattore che si esprimeva su un ciottolo meraviglioso dei sentieri del Drôme, sapendo che non c’è mai nulla di forzato nella magia di una forma minerale, e che esse portano soltanto il ricordo di epoche antidiluviane, necessariamente “geniali”.
E che facciano parte dell’inconscio pietrificato, avrebbero aggiunto i surrealisti parigini, grandi ammiratori del fattore.
Che cosa vedo, che cosa ho visto guardando le Dolomiti? Merletti, guglie, pinnacoli, torri, archi di spinta, ogive; poi campanili, cupole, altre torri, ma anche coralli, spugne e conchiglie, mille cose frammiste e sedimentate, che avrei potuto scorgere anche sulle facciate del palazzo del fattore Cheval, a Hauterives. Guardando indietro, penso al palazzo dei sogni e al fattore Cheval, un artista eroico che ha passato la vita a costruire, pietra dopo pietra, il suo tempio della natura (poi detto Palazzo dei sogni), nelle colline della Drôme, in Francia. Non c’è dubbio che il fatto stesso di vivere vicino ai contrafforti delle Alpi abbia ispirato il nostro eroe, visto che il suo palazzo è un accumulo geo-archeologico, come il tempio di Angkor o i templi induisti dell’India. Il vegetale vi si affianca al minerale; la sedimentazione degli stili lo rende quasi un’opera naturale, al tempo stesso ingenua e sacra. Lo stesso vale per le Dolomiti, che avrebbero confermato, se l’avessero vista, l’intuizione iniziale del fattore che si esprimeva su un ciottolo meraviglioso dei sentieri del Drôme, sapendo che non c’è mai nulla di forzato nella magia di una forma minerale, e che esse portano soltanto il ricordo di epoche antidiluviane, necessariamente “geniali”.
E che facciano parte dell’inconscio pietrificato, avrebbero aggiunto i surrealisti parigini, grandi ammiratori del fattore.
Fortezza Bastiani e valzer
La sera, alla luce della luna, vedo nelle Dolomiti una fortezza immaginaria, tra due mondi, la fortezza Bastiani del “Deserto dei Tartari” di Dino Buzzati. Immagino le orde di Cimbri, Longobardi, Bavari che hanno
tutte visto rizzarsi davanti a sé i monti pallidi, rischiarati dalla
luce d’oriente, prima di riversarsi nell’edificio che nascondeva loro lo
scenario del mare, di Genova, Venezia o Ravenna; la maggior parte passò
per la Val Rendena, ai piedi del massiccio del Brenta. Erano un ultimo
resto di luna prima del pieno sole. Erano i Tartari, le cui ultime
reincarnazioni furono certamente i soldati austro-ungarici del 1915,
venuti a portare una guerra bianca, lunare, nei deserti delle vette.
hanno
tutte visto rizzarsi davanti a sé i monti pallidi, rischiarati dalla
luce d’oriente, prima di riversarsi nell’edificio che nascondeva loro lo
scenario del mare, di Genova, Venezia o Ravenna; la maggior parte passò
per la Val Rendena, ai piedi del massiccio del Brenta. Erano un ultimo
resto di luna prima del pieno sole. Erano i Tartari, le cui ultime
reincarnazioni furono certamente i soldati austro-ungarici del 1915,
venuti a portare una guerra bianca, lunare, nei deserti delle vette.
In una stube di Campiglio, dopo il calar della notte, vicino alle Dolomiti color indaco, mi sembra di essere in un’Austria-Ungheria italiana; comincio a divagare, aiutato dalla birra austriaca: “Poi la fortezza è stata integrata nell’Impero d’Oriente, e i Monti pallidi collegavano la penisola italiana al cosiddetto Oceano interno, che si estendeva dalla Lorena alla Vojvodina e alla Galizia, dominato un tempo dagli Asburgo di Vienna. Uno dei cuori politici e militari d’Europa si trovava allora nelle montagne e il Trentino ne faceva parte, come i Sudeti o la Transilvania. Montagne di paesi cechi e slovacchi, Alpi italiane, Carpazi, l’impero degli Asburgo ha perduto a uno a uno questi tentacoli che gli permettevano, da Vienna, di diramarsi sull’Europa. L’impero ha avuto la sua ultima regina lunare con Sissi, poi si è disintegrato sull’aria di un valzer, una marcia Radetzky che si può ancora sentire durante il carnevale asburgico, a fine luglio, a Madonna di Campiglio.”
È rimasto qualcosa delle danze viennesi, intessute d’armonia, di fasto e di stabilità, nello spettacolo delle Dolomiti del Brenta e a Madonna di Campiglio.
E qualcosa delle Dolomiti è indubbiamente rimasto nei racconti metafisici e lunari di Buzzati, come nell’idea della fortezza Bastiani.
La sera, alla luce della luna, vedo nelle Dolomiti una fortezza immaginaria, tra due mondi, la fortezza Bastiani del “Deserto dei Tartari” di Dino Buzzati. Immagino le orde di Cimbri, Longobardi, Bavari che
 hanno
tutte visto rizzarsi davanti a sé i monti pallidi, rischiarati dalla
luce d’oriente, prima di riversarsi nell’edificio che nascondeva loro lo
scenario del mare, di Genova, Venezia o Ravenna; la maggior parte passò
per la Val Rendena, ai piedi del massiccio del Brenta. Erano un ultimo
resto di luna prima del pieno sole. Erano i Tartari, le cui ultime
reincarnazioni furono certamente i soldati austro-ungarici del 1915,
venuti a portare una guerra bianca, lunare, nei deserti delle vette.
hanno
tutte visto rizzarsi davanti a sé i monti pallidi, rischiarati dalla
luce d’oriente, prima di riversarsi nell’edificio che nascondeva loro lo
scenario del mare, di Genova, Venezia o Ravenna; la maggior parte passò
per la Val Rendena, ai piedi del massiccio del Brenta. Erano un ultimo
resto di luna prima del pieno sole. Erano i Tartari, le cui ultime
reincarnazioni furono certamente i soldati austro-ungarici del 1915,
venuti a portare una guerra bianca, lunare, nei deserti delle vette.In una stube di Campiglio, dopo il calar della notte, vicino alle Dolomiti color indaco, mi sembra di essere in un’Austria-Ungheria italiana; comincio a divagare, aiutato dalla birra austriaca: “Poi la fortezza è stata integrata nell’Impero d’Oriente, e i Monti pallidi collegavano la penisola italiana al cosiddetto Oceano interno, che si estendeva dalla Lorena alla Vojvodina e alla Galizia, dominato un tempo dagli Asburgo di Vienna. Uno dei cuori politici e militari d’Europa si trovava allora nelle montagne e il Trentino ne faceva parte, come i Sudeti o la Transilvania. Montagne di paesi cechi e slovacchi, Alpi italiane, Carpazi, l’impero degli Asburgo ha perduto a uno a uno questi tentacoli che gli permettevano, da Vienna, di diramarsi sull’Europa. L’impero ha avuto la sua ultima regina lunare con Sissi, poi si è disintegrato sull’aria di un valzer, una marcia Radetzky che si può ancora sentire durante il carnevale asburgico, a fine luglio, a Madonna di Campiglio.”
È rimasto qualcosa delle danze viennesi, intessute d’armonia, di fasto e di stabilità, nello spettacolo delle Dolomiti del Brenta e a Madonna di Campiglio.
E qualcosa delle Dolomiti è indubbiamente rimasto nei racconti metafisici e lunari di Buzzati, come nell’idea della fortezza Bastiani.
Malghe
Val di Genova. Il fondo valle alpino restituisce l’atmosfera di un deserto biblico. L’angoscia che capita di trovarvi è bilanciata da una sorta di ebbrezza, che sorge quando il suono dei campanacci al collo delle mucche rende il silenzio più profondo. Solitudine, povertà, sole: una mescolanza rara. Nel medioevo, i proprietari delle preziose malghe dovevano essere spietati gli uni verso gli altri, come i pastori del Vecchio Testamento, che avevano sempre dietro di sé la propria tribù e il proprio gregge. Senza dubbio queste valli ospitano ancora ai nostri giorni dei vecchi pastori che ne sono la memoria, e profetano nella loro solitudine relativa.
Val di Genova. Il fondo valle alpino restituisce l’atmosfera di un deserto biblico. L’angoscia che capita di trovarvi è bilanciata da una sorta di ebbrezza, che sorge quando il suono dei campanacci al collo delle mucche rende il silenzio più profondo. Solitudine, povertà, sole: una mescolanza rara. Nel medioevo, i proprietari delle preziose malghe dovevano essere spietati gli uni verso gli altri, come i pastori del Vecchio Testamento, che avevano sempre dietro di sé la propria tribù e il proprio gregge. Senza dubbio queste valli ospitano ancora ai nostri giorni dei vecchi pastori che ne sono la memoria, e profetano nella loro solitudine relativa.
 Il potere di una cartolina
Il potere di una cartolinaIn una cartolina,vi è ancora qualcosa di fisico, e quindi di magico.
Ho spedito una veduta delle Dolomiti a un amico, al quale ho in seguito domandato, per curiosità, cosa vedeva. Mi ha risposto che vedeva un mondo scomparso, che lanciava ancora dei segni, impercettibili, che lo avvicinavano alle Dolomiti e ai loro segreti, perché la cartolina era stata spedita da “laggiù”. Come se i Monti pallidi avessero trasmesso qualcosa della loro potenza alla cartolina, agendo sempre nel presente, da un cassetto, da una mensola, magari nella luce di una casa del Gard; lontano dagli scenari di città.




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire